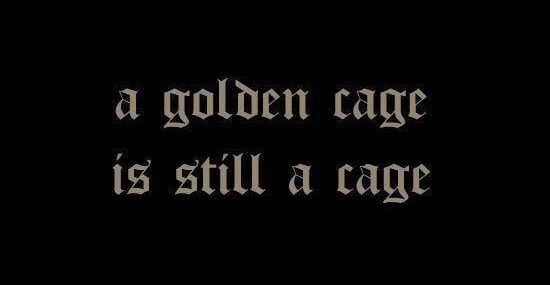Riceviamo e diffondiamo:
Abbiamo raccolto il racconto dellɜ compagnɜ francesɜ che prima di noi hanno preso parola su 269, a cui abbiamo deciso di fare eco traducendone il testo, che riportiamo di seguito, prima di narrare il nostro vissuto:
TESTO TRADUZIONE: https://rest25.noblogs.org/post/2026/02/15/abusi-allinterno-del-collettivo-269-liberation-animale-per-una-lotta-antispecista-che-non-sfrutta-l3-su3-attivist3/
Alcuni dei punti li richiamiamo, perchè già esplicitati dallɜ compagnɜ francesɜ:
- Verticismo e accentramento di potere:
Abbiamo riscontrato le stesse dinamiche descritte dallɜ compagnɜ francesɜ: favoritismi e simpatie personali. L’anarchia non è mai stata una corsa al vertice: tutto questo è sinceramente molto triste.
- Abilismo e performatività:
Un altro punto su cui riteniamo essenziale aprire una riflessione è la costante svalutazione della singola persona in un’ottica performativa e schiacciante in 269. Usare lɜ attivistɜ con l’idea che solo chi è emotivamente adattə o non dà mai alcun segno di cedimento è abilista, oltre che tossico. Ogni attivista è una persona, prima di essere una pedina da muovere a proprio piacimento. Sembra assurdo doverlo ribadire. Eppure, la partecipazione alle azioni in 269 viene valutata unicamente in ottica performativa, come se mostrare qualsiasi segno di vulnerabilità fosse una colpa. Questo atteggiamento muscolare, estremamente patriarcale e machista, per cui solo chi non commette l’ “errore” di mostrarsi nella propria fragilità è un membro degno, non è di certo un comportamento che potremmo definire “femminista”. Sembrerebbe che del femminismo 269 ne faccia vanto nella speranza, forse, di attrarre un pubblico attento all’intersezionalità delle lotte, ma la realtà è molto diversa. Abbiamo osservato, a malincuore, come questa soffocante politica della perfezione e della performance spesso venga assorbita da alcunɜ attivistɜ che la replicano in altri spazi, anche una volta fuori da 269.
“Pas de problème”, la sete di potere dei piani alti, la loro visibilità mediatica e la loro posizione sul trono rimangono intatte, intoccabili ed indiscusse.
- Culto del sacrificio e del martirio:
Quello che viene rafforzato è un culto del sacrificio e del martirio per sedare preventivamente rivolte interne, facendo leva sul senso di colpa che le persone antispeciste provano nei confronti dellɜ compagnɜ non umanɜ. La mentalità settaria impera, creando un terreno fertile per una gerarchia che sfrutta la manipolazione emotiva come strumento per auto-conservarsi e mantenersi intatta nel tempo. Un punto di collegamento molto ben analizzato dallɜ compagnɜ francesɜ, che sottoscriviamo in toto.
- Screditamento delle altre realtà:
Nel culto di 269 rientra anche la svalutazione dei metodi utilizzati da altri gruppi o collettivi antispecisti. Lungi da noi negare il sacrosanto diritto di critica costruttiva verso le metodologie usate da noi stessɜ e da altre realtà, che sappiamo essere sempre migliorabili. Tuttavia, spacciare i propri metodi come gli unici praticabili e validi mostra chiaramente quanto poco spazio di confronto, dialogo e autocritica ci sia in 269, uno spazio privo di discussioni ma ricco di retorica. È molto chiaro che le smorfie da première dame bianca sono il leitmotiv di chi si spartisce il potere in 269: speravamo che almeno ci fosse del merito alla base di tanta arroganza.
- Terfismo:
L’indisponibilità ad ascoltare e a mettersi in discussione, figlia di quell’approccio identitario così ben descritto dallɜ compagnɜ francesi, rende ancora più avvilenti e dolorose esperienze già di per sé violente, come ad esempio lo stato di fermo in caserma dopo un’azione. L’identificazione, il deadname urlato dalla polizia, le foto segnaletiche e le relative occhiatacce quando espressione ed identità di genere non collimano, sono tutti segni di una silenziosa ma inaudita violenza. Ancor più feroce quando non ci sono compagnɜ dispostɜ a mettersi in ascolto, validare la tua esperienza, ma soprattutto a renderlo un argomento valido. Ma come potrebbe esserlo, d’altronde? Se siamo già lì, già arrivate, già avanguardia, già le migliori, e a nessunǝ è concesso di dire altrimenti?
- Mancanza di formazione legale:
Tutti questi meccanismi portano ad un altissimo e non casuale turn over in cui le persone vengono trattate come “pedine” sacrificabili: vera e propria carne da macello.
- E i soldi?
La partecipazione alle azioni implica dei costi estremamente ingenti per coprire i materiali, i mezzi di trasporto, le spese legali e processuali. In una realtà sana, con principi di solidarietà interna e attenta alle disuguaglianze sociali, di solito le spese vengono coperte tramite le donazioni che il progetto riceve, attraverso raccolte fondi apposite, e solo chi ha la possibilità di contribuire sceglie di farlo per la causa. Non in 269: ogni azione richiede centinaia di euro che ogni attivista è costrettǝ a sborsare di tasca propria, pena l’esclusione. Questa dinamica viene rinforzata dalla retorica del sacrificio “lo state facendo per lɜ compagnɜ non umanɜ, pensate a loro”, ancora una volta facendo leva sul senso di colpa e portando le persone a rimanere in seria difficoltà economica pur di potersi sentire utili alla lotta. Nessuna rete di supporto: se nel collettivo vige il reato di pensiero figuriamoci cosa possa comportare chiedere aiuto. Dei numerosi crowdfunding lanciati dalle pagine ufficiali dell’organizzazione nel corso del tempo – compreso quello attivo nel presente – allɜ attivistɜ alla base non arriva che qualche misero spicciolo, se si è fortunatɜ.
L’intero assetto materiale di 269 denota un atteggiamento profondamente classista, in cui la lotta diviene una prerogativa bianco-borghese di chi se la può permettere.
E’ arrivato il momento di far crollare le torri d’avorio e di abbattere ogni gerarchia interna ancorata a “le grand plan” di mantenere sé stessa inalterata e inarrivabile.
In un mondo che ci scoraggia a farlo, il primo atto davvero rivoluzionario che possiamo compiere è prenderci cura dei nostri corpi e della nostre psiche per costruire una comunità basata su legami sinceri, in cui poter contare l’unə sull’altrə.
Offrire, ricevere cura e costruire solidarietà concreta sono presupposti indispensabili per creare una comunità solida che possa lavorare per una liberazione animale intersezionale.
Senza radici sane, l’albero crescerà sempre marcio: nessuna lotta può durare nel tempo e portare ad un cambiamento radicale se non condotta in modo sostenibile per tuttɜ.
269 LA è, invero, soltanto un esempio di come i gruppi che accentrano il potere, che si appropriano di retoriche politiche radicali e usano con opportunismo lɜ attivistɜ, siano dannosi per la causa antispecista: nel corso degli anni 269, così come tanti altri spazi di attivismo, ha bruciato compagnɜ a cui è stata risucchiata l’anima, che per sopravvivere hanno avuto bisogno di allontanarsi dalla militanza.
Non vogliamo più scendere a compromessi: l’unico modo in cui riteniamo giusto vivere la Resistenza a fianco dellɜ compagnɜ non umanɜ è adoperarci attivamente per costruire spazi di crescita condivisa che siano sani per loro, per noi, per te che ci hai letto e per chiunque si aggiungerà.
E no, non saranno delle velate ed infondate minacce di denuncia (ricordiamolo – sempre da “compagnɜ” sedicenti “anarchichɜ”) a tapparci la bocca. Ci vuole davvero del gran coraggio per definirsi anarchichɜ, radicalɜ di sinistra, e poi ricorrere allo spauracchio del braccio armato dello Stato.
Piuttosto, pensiamo sia più utile, per essere alleatɜ della liberazione animale, concentrare le nostre energie nel prenderci cura dei nostri spazi con serietà e bontà di intenti, senza mire espansionistiche o l’ossessione della visibilità. Abbiamo necessità di liberarci per poter liberare, di emanciparci per non replicare o vederci replicate addosso, in loop, le stesse logiche del sistema che opprime noi e le persone non umane.
COSTRUIAMO INSIEME UNA LOTTA DI LIBERAZIONE ANIMALE EMANCIPATA DA OGNI FORMA DI OPPRESSIONE.
Nota a margine: 269 non ha l’esclusiva dell’azione diretta!
Se senti il richiamo a contribuire attivamente alla causa antispecista, entra in contatto con altre persone e gruppi locali per scoprire che alternative più sane esistono già, che il tuo contributo è prezioso e che nello spazio adatto a te il tuo apporto verrà valorizzato.